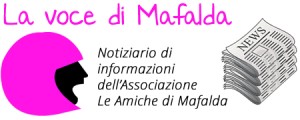“Il servizio più grande che una donna possa rendere alla propria comunità è quello di essere felice”
Mafalda, la bambina sarcastica del fumettista argentino Quino che abbiamo scelto come simbolo della nostra associazione, guardando sua mamma che sfaccendava con lena per la casa, le chiese “Mamma, se tu potessi vivere, che cosa faresti?”. Ovvero, “mamma, se fossi libera di scegliere, che cosa vorresti essere, che cosa vorresti fare?”.
Sì, che cosa faremmo noi donne se davvero fossimo libere dai condizionamenti, dalle aspettative di famiglia e comunità, dall’idea di ciò che dobbiamo essere e fare, dal senso di responsabilità lentamente e secolarmente instillatoci?
Simone De Beauvoir scriveva nel secolo scorso che per la donna è più agevole la passività della subordinazione che “l’angoscia e la tensione di una vita autenticamente vissuta”[1].
Ma in fondo, chi di noi si sente realmente subordinata? Riusciamo a vedere i lacci e lacciuoli che ci tengono legate ancora oggi a un destino preordinato, in una società dove le opportunità per studiare, lavorare, vivere la propria sessualità sono più che mai aperte?
Questi lacci riusciamo forse a vederli e a percepirli, seppur in minima parte, tutte le volte che singolarmente cerchiamo uno spazio di libertà tutto personale: nelle piccole scelte sul lavoro, nelle ore che decidiamo di passare fuori con le amiche o per impegno professionale, nella decisione di lasciare una relazione affettiva che ci fa male. In queste e in mille altre condizioni di piccola rivolta quotidiana, possiamo arrivare a sentire questi lacci che si stringono attorno con maggiore forza, proprio quando abbiamo cominciato a muoverci. Li possiamo anche vedere nella reazione che suscitano tutte quelle donne “diverse”, persone che hanno scelto o si sono trovate loro malgrado a vivere una vita diversa da quella normalmente attesa per una donna: donne sole, o che hanno professioni considerate specificamente maschili, o che non hanno avuto o voluto o potuto avere figli, o che amano altre donne, o più semplicemente hanno un’apparenza diversa. Le reazioni delle persone non sono precisamente amichevoli, ma piuttosto di sospetto, di biasimo, a volte di condanna ed emarginazione. Perché la “segregazione ugualitaria” delle donne è di questo che si alimenta: cercare di tenere al loro posto le donne, ovvero al posto e al ruolo che è stato scelto per loro dalla società e dalla cultura del momento, attraverso la spinta, l’elogio, il premio, la gratificazione popolare di tale ruolo.
Non è il ruolo in sé che è sbagliato o che non funziona, ma il fatto che sembri essere un destino predeterminato per tutte, che non ci si arrivi personalmente come una scelta di libertà: è questo che lo rende una possibile fonte di infelicità e di frustrazione.
Mafalda, con il suo sguardo di bambina, lo aveva capito. E’ quel suo sguardo che vogliamo mantenere: di curiosità, di critica, di ribellione e di solidarietà.
Le donne devono tenere in grande considerazione il loro malcontento e la loro inquietudine, perché sono il primo segno della pretesa alla felicità.
Cominciare a parlarne apertamente, l’una con l’altra, aiuta a mettere in dubbio le convinzioni più diffuse e più salde sulla cosiddetta normalità femminile, per riaprire quelle possibilità di sviluppo individuale che sono state inibite dal condizionamento.
[1] Simone De Beauvoir, “Il secondo sesso”[slidercc id=72]